Da dove deriva il modo di dire: "Mettere una croce sopra"?
ORIGINI E TERRITORIO
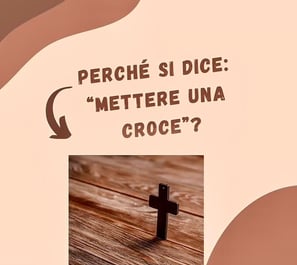
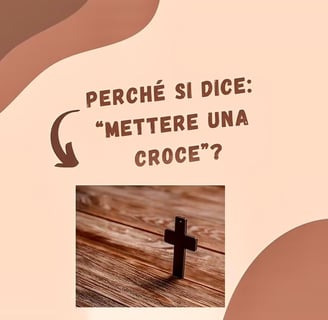
Introduzione
Il modo di dire "Mettere una croce sopra" è largamente utilizzato nel linguaggio quotidiano per indicare la decisione di abbandonare definitivamente una specifica questione, rinunciare a una speranza, o accettare una perdita in maniera irrevocabile. Tuttavia, per comprenderne l'origine del motto, è necessario esplorare le sue radici storiche e culturali soffermandosi sui contesti in cui si è formato e, soprattutto, ciò che ha permesso di arrivare fino ai nostri giorni. Cerchiamo dunque di fare un pò di chiarezza.
L'evoluzione nel tempo
Nei tempi dell'Antica Roma, si usava "Mettere una croce sopra" con lo scopo di segnare i debiti che non potevano essere riscossi. I crediti non esigibili, infatti, venivano annotati in appositi registri con una croce. Questo segno indicava l'abbandono delle speranze di recuperare il credito.
Oltre al contesto romano è importante soffermarsi anche sulla rilevanza in ambito ecclesiastico. Nel cristianesimo, la croce assume ancora oggi una valenza simbolica profonda e poliedrica. Oltre al ricordo della crocifissione di Cristo, e dunque, un'immagine di profondo dolore, i cristiani leggono allo stesso tempo il segno Resurrezione e quindi della speranza più profonda, della fede. In questa sede, probabilmente, la croce diviene semplicemente simbolo della fine terrena. Non a caso, durante gli ultimi attimi di vita, il sacerdote è solito impartire la cosiddetta estrema unzione, segnando il capo della persona con l'olio benedetto. Dopo la morte sopra la bara del defunto viene sovente posta una croce, segno appunto di fine, ma anche di speranza nell'Aldilà.
La crux desperationis in filologia
Spunti interessanti si trovano però anche in campo filologico. La filologia è quella disciplina che si occupa di ricostruire e riportare i testi alla loro forma originaria attraverso rigide analisi e studi comparativi sulle fonti a disposizione degli studiosi. In questo branca si è soliti parlare di "crux desperationis". La "croce della disperazione" è una pratica per la quale si pone il simbolo della croce accanto a quei passaggi considerati corrotti o senza senso e che, dopo svariati fallimenti, non sarebbero stati ulteriormente corretti. Questa usanza era frequente soprattutto nei testi classici medievali e classici poiché era estremamente complesso risalire al testo originario.
Studi recenti in ambito linguistico hanno confermato questa evoluzione semantica, contribuendo a chiarire la sua persistenza nel linguaggio moderno.
Conclusione
La ricchezza del linguaggio italiano ci porta ad analizzare pratiche molto antiche, spesso di un valore intrinseco di non facile traduzione. Eppure, espressioni idiomatiche come questa riescono ancora a far parte della lingua parlata. Conoscerne le radici non solo arricchisce la nostra conoscenza della lingua, ma ci permette anche di apprezzare maggiormente la storia e la cultura che hanno formato quello che siamo e diciamo oggi. Attraverso l'analisi storica e l'indagine linguistica, abbiamo visto come un concetto di abbandono e disperazione possa trasformarsi in un simbolo linguistico di decisione irrevocabile.
Fonti:
Gentile Maria Luigia, Lingua e Simbolo nella Tradizione Medievale.
Pasquali Giorgio , Filologia e Storia dei Testi.
